The Technological Republic
Alexander C. Karp – Nicholas W. Zamiska
Crown Currency 2025
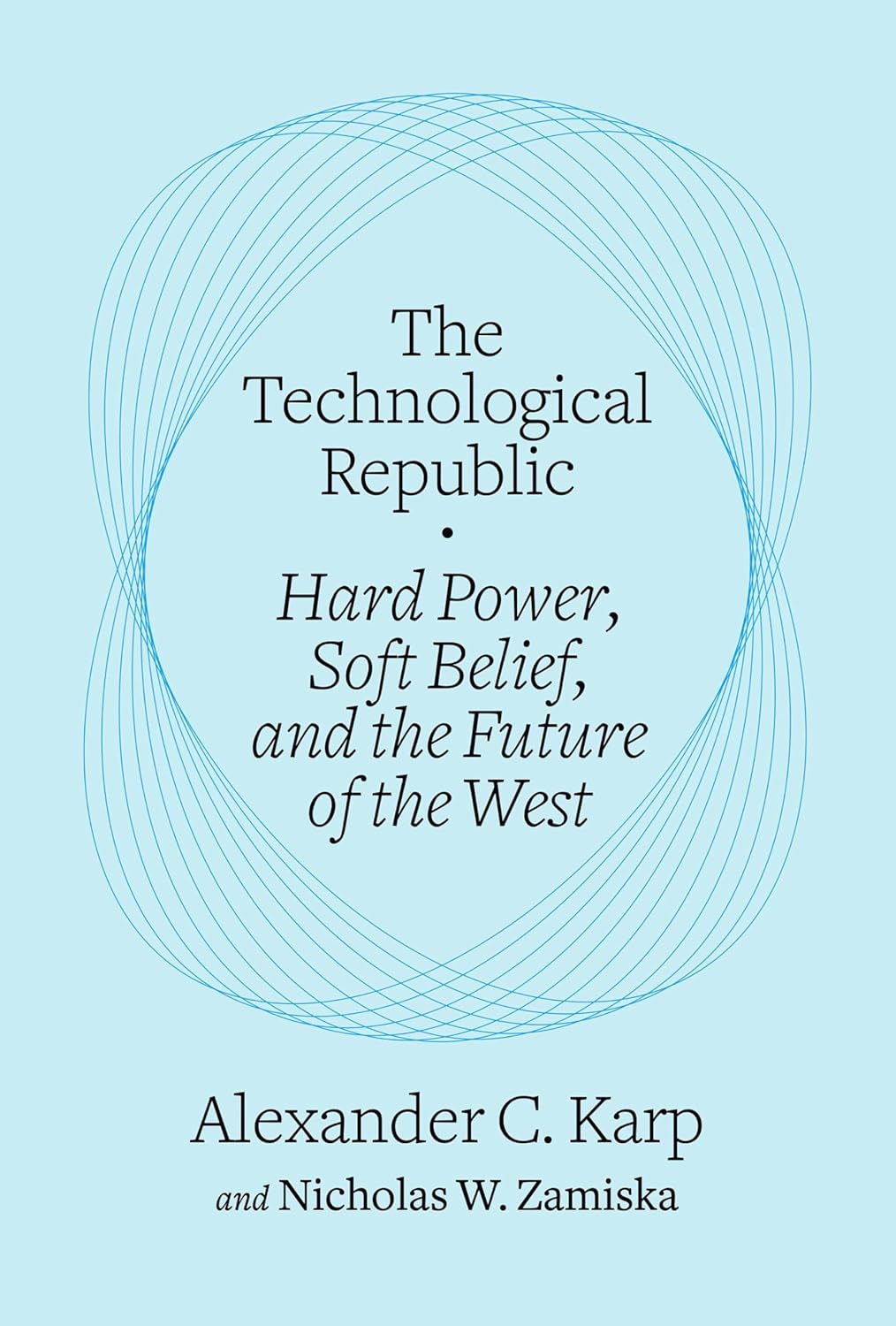
In The Technological Republic, Alexander C. Karp propone una visione ambiziosa e profondamente ideologica: l’alleanza tra intelligenza artificiale, cultura nazionale americana e nuovo spirito repubblicano come fondamento di un futuro egemonico e ordinatore. L’IA, nella sua lettura, non è solo uno strumento tecnico, ma diventa matrice di senso, principio identitario, risposta politica e antropologica alla crisi di legittimità delle democrazie occidentali.
L’elemento più interessante e al tempo stesso problematico del libro è la saldatura tra tecnologia e patriottismo americano. Per Karp e Zamiska, l’intelligenza artificiale è la chiave per una rinascita dell’ideale repubblicano, in opposizione non solo a modelli autoritari come quello cinese, ma anche a un pensiero progressista che – a suo dire – avrebbe rinunciato alla costruzione di orizzonti condivisi. L’autore denuncia la frammentazione identitaria della sinistra contemporanea e propone, in alternativa, un modello forte di civiltà tecnologica americana: inclusiva a parole, ma selettiva nei presupposti.
Questa posizione riecheggia quella di studiosi come il filosofo Benjamin Bratton (The Stack: On Software and Sovereignty), che ha descritto l’infrastruttura digitale globale come una nuova forma di sovranità. Ma laddove Bratton esplora la complessità sistemica della governance tecnologica, Karp e Zamiska assumono un tono programmatico e normativo, a tratti persino salvifico. La loro “repubblica tecnologica” appare come un progetto ideologico totalizzante, dove l’innovazione si fonde con una visione moralizzata della leadership americana nel mondo.
Rimuovere ogni discussione sulle disuguaglianze
Il lessico impiegato – che tende spesso alla retorica epica – rimuove qualsiasi interrogativo sulle disuguaglianze e sui costi sociali della trasformazione digitale. È questo, forse, il limite più grave dell’opera: The Technological Republic si presenta come un saggio di civiltà, ma elude del tutto la questione della giustizia sociale. Nulla si dice delle condizioni di lavoro nel capitalismo delle piattaforme, della governance algoritmica che discrimina, dell’asimmetria tra chi progetta l’IA e chi la subisce. Autrici come Ruha Benjamin (Race After Technology) o Virginia Eubanks (Automating Inequality – How High-Tech Tools Profile, Police, and Punish the Poor, sottotitolo emblematico: come gli strumenti high-tech profilano, controllano e puniscono i poveri) ci hanno mostrato come l’innovazione possa, in assenza di consapevolezza politica, riprodurre e amplificare i meccanismi di esclusione. Ma Karp e Zamiska, su questi temi, tacciono.
Il loro attacco al pensiero critico di sinistra sembra funzionale più alla costruzione di un nemico retorico che a un dialogo reale. Ciò che Mark Fisher ha definito realismo capitalista – cioè l’incapacità della sinistra di immaginare alternative credibili – è un problema serio, ma richiederebbe una risposta che non si limiti alla celebrazione di una nuova élite tecnico-nazionale. Così come il desiderio di orizzonti comuni, pur legittimo, non può ignorare che la frammentazione non è frutto di debolezza morale, ma spesso conseguenza di diseguaglianze strutturali.
In definitiva, The Technological Republic è un libro potente, ma sbilanciato. Propone una narrazione forte – e in questo affascina – ma lo fa eludendo il conflitto, la pluralità, il dubbio. Trasforma la tecnologia in destino e la repubblica in algoritmo, senza interrogarsi su chi resta fuori da questa promessa. E senza riconoscere che nessuna rigenerazione democratica è possibile senza passare per la strada, lunga e faticosa, della giustizia.
Piervincenzo Di Terlizzi
Nota a margine: le ricadute in abito educativo in Italia
Aluisi Tosolini
Nel corso di questa estate, a partire dal testo di Aresu (Geopolitica dell’intelligenza artificiale, presentato su Casco Open Magazine qualche settimana fa) io e Piervincenzo Di Terlizzi (dirigente scolastico a Pordenone) abbiamo cercato di approfondire alcune questioni legate non solo e non tanto allo specifico dell’intelligenza artificiale quanto piuttosto ad alcuni concetti chiave del contesto culturale statunitense che negli ultimi anni sono divenuti mainstream e stanno influenzando in maniera massiccia anche gli scenari politico-culturali-educativi del nostro paese.
E’così che siamo giunti ad approfondire le riflessioni elaborate da Peter Andreas Thiel e dal suo gruppo.
Peter Andreas Thiel e Palantir
Nella presentazione del volume di Aresu è stato evidenziato il ruolo di Thiel non solo nella battaglia contro il multiculturalismo ma anche nella fondazione di imprese, l’ultima delle quali è la famosissima Palantir. Il nome Palantir proviene dal libro Il signore degli anelli dove sono citate delle sfere magiche che servono per comunicare a distanza. Il termine sta a significare, ed è emblematico, “coloro che sorvegliano da lontano”. E questo fa Palantir: analizza dati in modo così preciso che, avendo accesso ad una pluralità di fonti di dati, sta in sostanza costruendo la possibilità di un controllo sociale estremamente significativo dove la “sorveglianza” delle singole persone è portata al massimo livello.
Proprio oggi Il Post ha dedicato un articolo molto preciso e dettagliato a Palantir e ad esso rimandiamo.
È dentro questo contesto che abbiamo incontrato e studiato il testo The Technological Republic pubblicato nel febbraio del 2025 e che vede come autori due importantissime personalità di Palantir, ovvero Alexander C. Karp, cofondatore e amministratore delegato di Palantir Technologies e Nicholas W. Zamiska, responsabile degli affari societari e consulente legale dell’ufficio dell’amministratore delegato di Palantir Technologies
Il primo, laureato all’Haverford College e alla Stanford Law School, ha dottorato in teoria sociale presso l’Università Goethe in Germania mentre il secondo si è laureato allo Yale College e alla Yale Law School. Insomma non due sprovveduti nell’area delle scienze umane e politiche,
Il libro, non ancora pubblicato in italiano, ha un titolo esplicito che potremmo così tradurre: La Repubblica tecnologica. Potere forte, convinzione debole e il futuro dell’Occidente.
La recensione di Piervincenzo Di Terlizzi evidenzia con chiarezza la proposta e i suoi limiti. Ma anche la forza retorica di un pensiero che vuole “ricostruire la Repubblica Tecnologica” promuovendo una cultura della proprietà e della responsabilità, criticando l’eccessiva burocrazia governativa e l’attuale riluttanza ad affrontare questioni fondamentali di identità e scopo nazionale.
L’Occidente e la sua mitizzazione
Centrale in questo ragionamento è l’Occidente, termine che così spesso torna ogni giorno nel dibattito, anche educativo (si vedano le indicazioni nazionali 2025 per le scuole del primo ciclo).
Il concetto di “Occidente” e di “civiltà occidentale” ha subito negli ultimi decenni, secondo Karp e Zamiska, una profonda decostruzione. Se in origine la “civiltà occidentale” era un concetto che identificava un insieme di valori culturali e politici radicati nell’antichità (Roma e Grecia) che poi si erano estesi fino all’era moderna, negli ultimi decenni molti autori hanno cercato di negarne:
- alcuni studiosi hanno definito l’occidente una “grande narrazione essenzialmente fittizia“, un “racconto” imposto sulla storia piuttosto che emergente da essa.
- altri hanno collegato l’occidente alle teorie imperiali di dominazione. Tra questi la Edward Said, autore di Orientalism
- alcuni, come Kwame Anthony Appiah, hanno sostenuto che l’idea di civiltà occidentale è stata “nel migliore dei casi fonte di grande confusione” e “nel peggiore dei casi un ostacolo ad affrontare alcune delle grandi sfide politiche del nostro tempo“.
Make America Great Again
Nonostante queste critiche e la loro diffusione (“molti oggi, in particolare nella Silicon Valley, sono a malapena consapevoli del suo ruolo nel plasmare e strutturare il discorso contemporaneo“), gli autori del libro sottolineano l’importanza del “recupero e riabbraccio di un senso di identità nazionale e collettiva“, con l’obiettivo dichiarato di “preservare il vantaggio geopolitico duraturo ma fragile che gli Stati Uniti e i loro alleati in Europa e altrove hanno mantenuto sui loro avversari“. I due autori, sulla scorta del saggio del 1998 in cui Thiel (The Diversity Myth : Multiculturalism and Political Intolerance on Campus) attaccava frontalmente l’idea del multiculturalismo, sostengono che in questi anni abbiamo assistito allo svuotamento della mente americana e all’abbandono di ogni progetto politico più ampio. Scrivono: la “tolleranza di tutto spesso costituisce la credenza in nulla” indicando come il vuoto che il multiculturalismo ha creato è stato poi riempito dal mercato e dalla logica del consumo superfluo e del puro guadagno. Ciò ha impedito di articolare un “senso di scopo nazionale” o una “visione condivisa della comunità a cui apparteniamo” portando a una riluttanza ad affrontare “questioni fondamentali” e a perseguire obiettivi di difesa nazionale.
Gli autori al contrario, auspicano una “ricostruzione di una repubblica tecnologica” che richieda la “riaffermazione di una cultura e di valori nazionali“.
Il multiculturalismo spinto all’estremo, inteso come un’indiscriminata tolleranza di tutte le visioni e l’abbandono di ogni identità e valore condivisi, non solo non ha più senso ma è attivamente dannoso, è percepito come una “credenza di lusso” che l’élite può permettersi, ma che suona totalmente fuori dal mondo per le persone nelle parti meno privilegiate della società.
La soluzione proposta da Karp e Zamiska è un ritorno a una forte identità e scopo nazionale e collettivo, che sia in grado di unire le persone e di consentire alle democrazie di competere efficacemente nel “secolo del software”.
E per questo serve l’hard power, figlio della connessione tra politica della potenza e intelligenza artificiale. L’IA è considerata la base della “hard power” nel ventunesimo secolo. L’era atomica sta giungendo al termine, e una nuova era di deterrenza sarà costruita sull’IA. Sarà essenziale sviluppare la prossima generazione di armamenti basati sull’IA, come gli sciami di droni senza pilota e i robot, che domineranno il futuro campo di battaglia. La capacità di sviluppare strumenti per impiegare la forza contro un avversario, insieme a una minaccia credibile di usarla, è spesso il fondamento di qualsiasi negoziazione efficace. L’esitazione nel perseguire la superiorità tecnica nell’IA militare sarà penalizzata, poiché gli avversari procederanno senza indugio.
La rivoluzione del buon senso?
In Italia alcune delle riflessioni e proposte contenute in The Technological Republic fanno da sfondo al libro La rivoluzione del buon senso. Per un paese normale pubblicato a fine luglio 2025 da Guerini e Associati. Chi ne è l’autore? Il ministro dell’istruzione e del merito, Giuseppe Valditara. Un testo che, riprendendo l’idea di occidente e la critica alla dimensione interculturale e multiculturale del nostro tempo propone una “rivoluzione” (ovvero un re-volvere, girarsi e tornare indietro) così caratterizzata: “nessuna ricostruzione materiale di una nazione potrà fondarsi su solide basi senza una sua ricostruzione spirituale… senza una rivoluzione culturale che riporti la naturalità, la normalità di certi valori e di certi principi nella società, partendo dalle scuole, dalle università, per finire nei tribunali e quindi nella cultura. Serve insomma la rivoluzione del buon senso. Esiste in Italia una maggioranza morale di cittadini che crede nel futuro della nostra patria, che condivide le esigenze di serietà, di buon senso, di realismo, di una politica concepita per difendere il bene comune e gli interessi nazionali, una maggioranza morale che non ha dimenticato i grandi valori della nostra storia migliore, che sono alla base della nascita stessa della Repubblica e che nessuno Sessantotto o Settantasette, nessun rigurgito neocomunista, wokista o internazionalista potrà cancellare. È a questa maggioranza morale che noi dobbiamo rivolgerci, per mobilitarla a fianco di chi sta lavorando per ridare fiducia, speranza e forza alla nostra Italia” (pp 154-155).
E così, partendo dalla Silicon Valley siamo arrivati a noi. E alle nostre scuole, al senso dell’educazione, al ruolo della scuola oggi in Italia secondo il Ministro dell’Istruzione e del Merito.
Una mia ampia presentazione/recensione del volume di Valditara è disponibile qui 🔗
